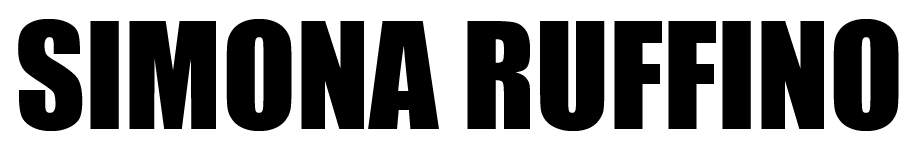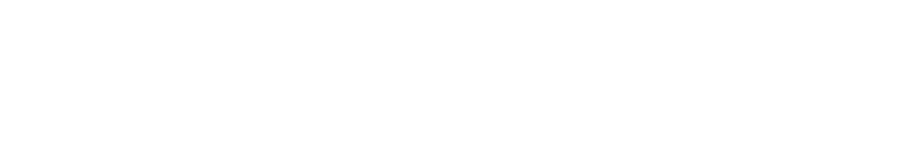Quando Walter Lippmann, quasi un secolo fa, scriveva che la nostra percezione della realtà è mediata da stereotipi e semplificazioni, anticipava con sorprendente precisione ciò che oggi viviamo quotidianamente. Attualmente, il consenso non si costruisce solo attraverso il dibattito razionale e pubblico, ma si genera all’interno di complesse reti algoritmiche e tecniche di comunicazione sofisticate che operano in modo quasi invisibile.
Viviamo immersi in un flusso incessante di notizie, dichiarazioni politiche e contenuti digitali. Eppure, raramente ci chiediamo quali meccanismi decidano ciò che vediamo e leggiamo. I contenuti digitali sono regolati da algoritmi che selezionano informazioni in base ai nostri comportamenti precedenti, creando quella che viene definita “filter bubble” o “echo chamber“: un ecosistema informativo autoreferenziale e autoalimentato. Tali bolle informazionali sono ideali per la manipolazione, perché limitano la varietà di punti di vista e rafforzano continuamente i nostri pregiudizi e le nostre convinzioni preesistenti.
Cosa insegnano le neuroscienze
Sul piano neuroscientifico, questo fenomeno è strettamente legato al “confirmation bias“, un meccanismo cognitivo che porta il nostro cervello a privilegiare le informazioni coerenti con ciò che già crediamo. Quando riceviamo informazioni che confermano ciò in cui crediamo, il nostro cervello produce dopamina, neurotrasmettitore legato alla gratificazione e al piacere. Al contrario, quando incontriamo opinioni divergenti, il nostro cervello percepisce stress e tensione, spingendoci a evitarle. È questo il meccanismo che le piattaforme digitali sfruttano per mantenere elevato l’engagement degli utenti: offrirci contenuti semplici, rassicuranti e polarizzanti, piuttosto che complessi e sfumati.
La politica internazionale contemporanea ne è un chiaro esempio. Durante le recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, l’opinione pubblica è stata fortemente polarizzata attraverso la diffusione massiccia di contenuti semplificati e altamente emotivi. La stessa dinamica si è verificata nella campagna per la Brexit nel Regno Unito, dove messaggi chiari, diretti e spesso fuorvianti hanno prevalso su analisi più approfondite. La polarizzazione della guerra in Ucraina offre ulteriori esempi: narrazioni diametralmente opposte, diffuse dai media russi e occidentali, creano bolle informative così distanti da rendere difficilissimo il confronto e il dialogo.
Queste tecniche manipolative includono il framing semplificato delle notizie, lo storytelling emotivo e l’uso strategico di bias come l’euristica della disponibilità, che ci spinge a credere maggiormente alle informazioni ripetutamente proposte, indipendentemente dalla loro accuratezza. Le conseguenze sociali e politiche di tali tecniche sono profonde: polarizzazione, frammentazione sociale e crescente sfiducia reciproca, condizioni che rendono le società più vulnerabili alla deriva autoritaria e meno resilienti alle crisi democratiche.
La politica, infatti, fa largo uso di queste tecniche manipolatorie, trasformando il dibattito pubblico in una guerra di slogan piuttosto che di idee. I cittadini, sempre più incapaci o poco disposti ad affrontare la complessità, finiscono per preferire risposte semplicistiche e immediate, rinunciando al dialogo e al confronto democratico. Questa situazione favorisce leader autoritari, che utilizzano tecniche persuasive e manipolatorie per creare un consenso basato più su emozioni primarie, come paura o rabbia, che sulla riflessione e il ragionamento.
COme contrastare l’architettura del consenso manipolativo
Per contrastare queste invisibili architetture del consenso serve un impegno concreto: un’alfabetizzazione digitale e cognitiva capace di farci riconoscere tecniche manipolatorie e bias cognitivi. Dobbiamo allenare la nostra mente al pensiero critico, verificando sempre la fonte delle informazioni, confrontando più punti di vista e accettando lo sforzo cognitivo della complessità. La recente esperienza degli attivisti iraniani, degli oppositori russi durante la guerra in Ucraina e dei movimenti democratici a Hong Kong mostra come sia possibile usare le piattaforme digitali per sfidare narrazioni dominanti e costruire una consapevolezza collettiva più autentica.
Le invisibili architetture del consenso non sono inevitabili. Diventano pericolose solo quando ci rassegniamo passivamente alla loro influenza, rinunciando al nostro ruolo attivo di cittadini informati e consapevoli. È possibile e urgente riprendere il controllo delle nostre capacità cognitive e critiche, perché soltanto così potremo proteggere davvero la nostra libertà di scelta, la nostra capacità di dialogo e, in ultima analisi, la nostra stessa democrazia.
Se vuoi saperne di più ne ho ampiamente parlato in “Non tutto come appare. Contro la cultura della manipolazione” Edito da Apogeo del Gruppo Feltrinelli. Lo trovi in libreria e in tutti gli store digitali.
Simona Ruffino